
Ho svolto per più di 20 anni l’attività di commerciale, viaggiando nel nord Italia. Per questo motivo ho vissuto poco il mio paese d’origine e ho perso il contatto con i miei coetanei e compaesani.
Quando ho interrotto questa attività per dedicarmi con passione e nel migliore dei modi al mondo del tartufo nel territorio del Lago di Garda, ho iniziato a creare collaborazioni con produttori locali di vino, olio extravergine d’oliva, formaggi, carni, pesce di lago e pasta artigianale. In questo nuovo percorso ho ritrovato le persone del mio territorio e costruito nuove relazioni legate alle eccellenze enogastronomiche gardesane.
Più di ogni altra cosa, mi ha colpito il profondo cambiamento del paesaggio agricolo. Un tempo queste campagne erano dominate da coltivazioni di mais, frumento, erba medica, qualche vigneto e tanti boschetti dove da ragazzino passavo in bici o con i motorini truccati li facevamo correre in quelle strade sterrate di campagna evitando le strade del paese.
Vivevo a Carzago della Riviera (BS) e mio cugino viveva a Bottenago, frazione di Polpenazze del Garda (BS), quelle strade di campagna erano la scorciatoia che collegava una parte di campagna di Carzago alla frazione Bottenago.
Di recente, con la bella stagione, sono tornato in quei luoghi in bicicletta. Sono rimasto stupito: oggi la campagna è ordinata, curata, tappezzata di vigneti, tanto da sembrare un giardino. Ma non la riconosco più: i boschetti sono spariti, i campi con coltivazioni a rotazione sono scomparsi, ci sono solo vigne.
Mi chiedo, esiste solo il vino?
Perché nell’enogastronomia si parla quasi esclusivamente di vino, perché si da solo priorità al vino? Soprattutto nelle zone come il Lago di Garda? Perché si dà così tanta priorità al vino, trascurando altri prodotti di eccellenza?
Va bene il vino ma, non c’è solo il vino da proporre e parlare al consumatore. Nel magico territorio del Lago di Garda, territorio che offre parecchie emozioni, offre anche l’olio extravergine DOP del Garda, agrumi storici, formaggi tipici, pesce di lago presidio Slow Food, caviale, casoncelli, spiedo bresciano, miele, Tartufo del Garda, salumi, dolci locali. Eppure, nella comunicazione e promozione turistica si parla quasi solo di vino.
Cosa c’è dietro alla produzione del vino? Se in Italia ci sono tantissime varietà di vini mi viene da pensare che nel settore vinicolo ci sia un grande margine di guadagno per le aziende agricole produttrici, è cosi?
Qui sollevo una questione molto importante e spesso trascurata nei discorsi sull’enogastronomia italiana: perché il vino riceve quasi tutta l’attenzione, a scapito di altri prodotti di eccellenza?
è una gemma nascosta, sottovalutata e quasi del tutto ignorata dalla grande narrazione gastronomica italiana.
Nelle aree collinari del Garda, in particolare nelle zone tra Brescia, Salò, Tignale, Valtenesi, Alto Mantovano, e persino nelle colline moreniche, crescono naturalmente diverse varietà di Tartufo, sia bianchi che neri, anche se meno celebri rispetto a quelli di Alba, Acqualagna, Norcia, Spoleto ecc. Eppure:
Eppure, il Tartufo Gardesano è totalmente assente da gran parte della comunicazione turistica ed enogastronomica della zona.
Il Tartufo ha una versatilità straordinaria: può sposarsi con tutti i grandi prodotti di un territorio, diventando collante tra mondi gastronomici diversi, ad esempio:
👉 Il Tartufo non è solo un prodotto di lusso: è un simbolo ecologico, culturale e sensoriale. È radice, tempo lento, stagionalità, rispetto del suolo, sostenibilità.
Nella viticoltura convenzionale si fa ampio uso di prodotti fitosanitari, in particolare:
In un vigneto convenzionale si possono fare anche 15-20 trattamenti all’anno, a seconda del clima e della pressione parassitaria.
Il 17 ottobre 2024 uscì al cinema Trifole – Le radici dimenticate, diretto da Gabriele Fabbro. A febbraio pubblicai in questo mio blog una breve anteprima di presentazione del film. E partecipai alla presentazione in anteprima al Castello di Grinzane Cavour. Un’avventura emozionante ambientata nel suggestivo mondo del Tartufo. Una storia toccante per molti aspetti, pensai che questo film avrebbe portato sul grande schermo una storia coinvolgente che riflette sull’importanza della natura e dei legami familiari, e così fu. Invito tutti quanti a vedere questo film e di comprendere tutti i messaggi, avvisi e lezioni del film.
Il film Trifole – Le radici dimenticate racconta la crisi del Tartufo bianco pregiato nelle Langhe: le cause della sua scomparsa – come la deforestazione, l’intensificazione agricola e il cambiamento climatico – sono le stesse che minacciano la presenza del Tartufo in tutta Italia e ben oltre. Non riguarda solo Alba, il Roero o le Langhe, ma interessa l’intero ecosistema tartufigeno nazionale, dal Nord al Sud, e non solo il Tuber Magnatum Pico, ma molte altre varietà dei tartufi.
Già nel mio primo articolo pubblicato il 21 aprile 2020, si lanciava un allarme, citando una ricerca scientifica che affermava:
“Tra 50 anni il tartufo potrebbe scomparire”.
Un monito che oggi, a distanza di pochi anni, appare purtroppo sempre più concreto.
Recentemente mi è apparso un articolo che parla del film Trifole – Le radici dimenticate, e dall’allarme da Alba e Roero e dalla fiera internazionale di Alba, per la scarsa produzione del Tartufo bianco pregiato, Tuber Magnatum Pico, per causa della mancanza dei boschi.
Il film Trifole – Le radici dimenticate e la tragica stagione 2024-2025 del tartufo bianco pregiato nelle Langhe e nel Roero si intrecciano in un’unica denuncia concreta e simbolica: la progressiva scomparsa del tartufo non è solo un problema agricolo o commerciale, ma il segnale tangibile di una crisi ecologica e culturale profonda. Il film, con il suo racconto emotivo e il forte richiamo alla memoria contadina, affonda le radici nella stessa realtà denunciata dai tartufai: boschi un tempo rigogliosi sono stati abbattuti per far spazio a colture intensive, alterando equilibri millenari che garantivano umidità, biodiversità e il delicato ciclo naturale del Tuber magnatum Pico.
La frase “NO ALBERI, NO TARTUFI”, evocata con forza dell’avvocato Roberto Ponzio, fondatore di “Museo del Tartufo-Galleria dei Ricordi”, risuona oggi in modo ancora più urgente, alla luce della peggior stagione da quarant’anni, in cui il tartufo è diventato quasi introvabile, i prezzi sono schizzati alle stelle e il rischio concreto è quello di perdere un simbolo identitario del territorio. Le misure istituzionali – come il censimento delle piante, i fondi per il recupero delle tartufaie e le indennità ai proprietari – non possono bastare senza una presa di coscienza collettiva: serve una gestione del paesaggio più lungimirante, che rimetta al centro gli alberi, i boschi e la complessità degli ecosistemi forestali. Il Tartufo, prodotto spontaneo e irriproducibile, diventa così il portavoce silenzioso di un equilibrio naturale che stiamo rompendo, ma che possiamo ancora provare a salvare con scelte responsabili, cura del territorio e nuovi modelli culturali ed economici.
Non possiamo pensare, con semplice scusante, che è colpa del clima che è cambiato. La colpa è nostra! Anche per causa di modelli economici aggressivi e monoculturali.
…La nipote, arrivata da Londra, ammira il paesaggio e lo descrive come ‘bellissimo’. Il nonno, mirabilmente interpretato da Umberto Orsini, la riprende e disapprova, rimpiangendo un tempo passato nel quale queste campagne erano ricche di alberi e boschi, mentre ora sono ricoperte soltanto da vigneti.
Esempio di come il cinema possa servire da catalizzatore per dibattiti sociali urgenti.
La massiccia eliminazione dei boschi a favore di colture intensive come i vigneti ha sicuramente contribuito al cambiamento microclimatico locale, e indirettamente, al cambiamento climatico globale.
I boschi svolgono un ruolo fondamentale nel regolare il clima:
Quando si sostituiscono i boschi con monoculture come i vigneti:
Non è solo il clima globale che cambia, ma cambiamo noi il clima locale attraverso le nostre scelte sull’uso del suolo. Quindi sì, la perdita dei boschi ha avuto (e continua ad avere) un impatto enorme. E non è una riflessione nostalgica: è una questione concreta di equilibrio ambientale e agricolo.
Hai letto quanto è prezioso il Tartufo del nostro territorio? Ora puoi portarlo direttamente sulla tua tavola!
Tartufo Nero Pregiato tutto l’anno, per i palati di tutti.
Sfoglia il nostro shop online e lasciati conquistare dal profumo autentico del Tartufo Nero Pregiato del Garda:
ha lo scopo di favorire la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione del tartufo della Valtenesi attraverso un’accurata e mirata manutenzione delle zone tartufigene da parte dei soci e tramite un’opportuna opera di informazione e pubblicizzazione.
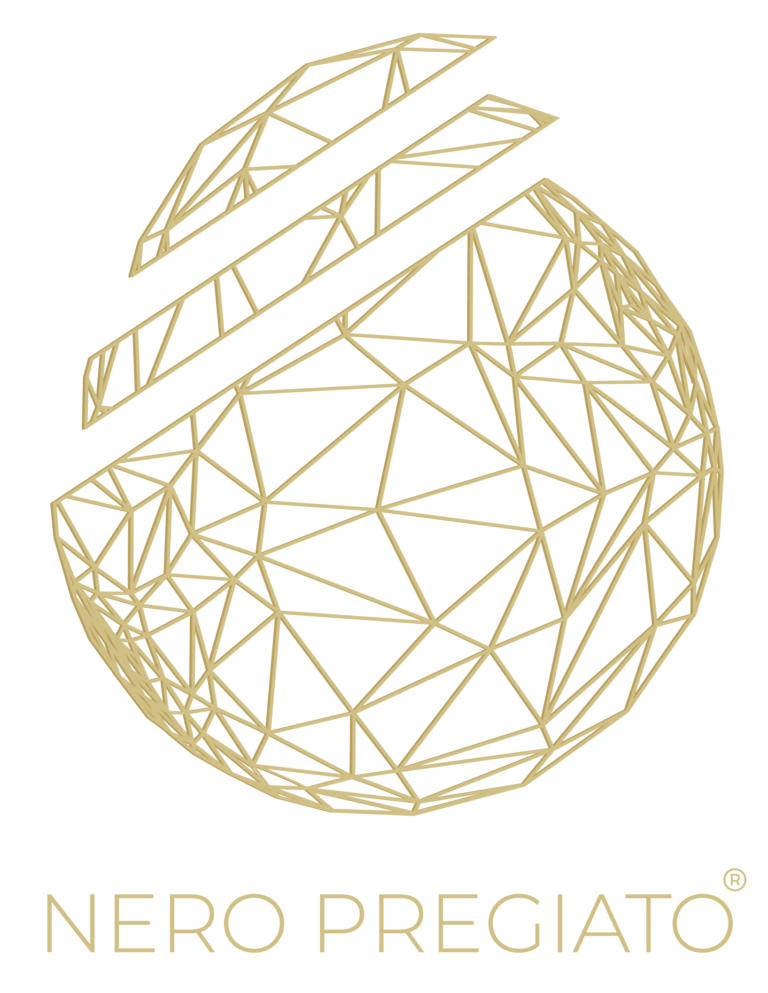
ITALUX Solution srl Via Vittorio Veneto, 7 Calvagese della Riviera CAP 25080 Brescia IT – P.IVA 04426430981 – VIES IT04426430981
Copyright 2024 © Tutti diritti riservati. Marketing by Webeon.it
Iscriviti alla Newsletter pregiata e ricevi lo sconto del 10% sul tuo prossimo ordine.